%%USERNAME%% %%ACCWORDS%% %%ONOFF%% |
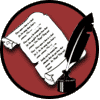 | No ratings.
Sulla scia di Dante |
| Nel mezzo del cammin di nostra vita mi ritrovai per una selva oscura ché la diritta via era smarrita. Della città volli varcar le mura e perseguir la strada ch’è maestra, ma tosto m’accorsi che l’insicura guida facea ch’io deviassi a destra. Gli chiesi sommesso di raddrizzare o che s’andasse almeno a sinistra. “Con le parole non s’ottien di fare,” egli mi disse parlandomi scortese, “una mèta tu abbi ad indicare.” “Credo ch’io voglio a fine d’ogni mese trovar quell’energia che scaldar possa la mente e il corpo mio che ad imprese aspirano come al calcio le ossa,” dissi alla guida che ora m’osservava. “A me sembra di capire ch’è una scossa che tu cerchi,” s’espresse lui e si stava ritto in piedi e braccia al petto. “Stramazzarti può però o t’aggrava nel tuo male e ti muori nel tuo letto.” “Son convinto: non s’avvera il testé, io m’attendo ch’una scossa diletto renda me a me com’agli altri com’a te. Per principiar con amore, Beatrice conoscer vorrei. Non dimandar perché.” “Amico, non son io una meretrice,” fé la guida che si nomina Tommaso, “tu mi paghi, è lo vero,” egli dice, “ma se femmina cerchi, usa il naso, lo tuo e non quello d’altro messere ch’à da pensar non a te, ma al suo caso.” “Quel che di Beatrice devi sapere, Tommaso mio, è ch’ella tanto gentil’e tant’onesta pare…” “Come? Parere? Se solo pare, ella non vuoi gentile e onesta come la descrivi quivi,” dice l’interlocutor mio, scurrile. “Ella pare quand’appare, non capivi? Sempre è, che paia o non appaia.” “Ma dov’è ‘sta Beatrice? Ella è ivi o sta altrove? E’ forse in legnaia? O in mezzo alle capre? Io vo’ vedere.” “Ella è qui,” diss’io, “perenne gaia, in test’a me.” E fo come tenère la cervice coll’indice. Lui scoppietta come fuoco sfavillante: mantenere vuolsi serio ma risata schietta prorompe dal suo petto e gl’agghigna il faccione. “Il tuo fare non rispetta il sentir mio e il mio cor digrigna,” volli sì rimproverarlo. Lui mi fece grandi scuse e m’offrì della vigna il succo del frutto suo che fece ritornar me di buonumore e la strada riprendemmo dopo d’una prece. Fitta assai si fe’ la selva, brada, scura ed intricata. Io tenea la testa alta a cercar cogl’occhi il cielo. “Bada,” d’un tratto disse Tommaso: “fa festa col cervello chi rischia d’inciampare tra pericoli del suolo perché desta è l’attenzione a luce che scompare,” e mi resse mentr’io cadevo fesso per un sasso traditore che celare si facea dall’erba alta. “Fin adesso ti va bene,” poi aggiunse in ton di sfida, “ch’io ti son davvero amico spesso.” “Il ciel veder volevo che m’è guida,” urlai. “Se il cielo guati tropp’a lungo, Beatrice in testa ti resta e le grida tue non la faran materia, ti pungo?” domandò facendomi arrossire. “Alla dura gogna mi terrai a lungo?” chiesi con sguardo supplice d’ire. “Con te vien che mi comporto amaro, tal con mio figliolo. Son le tue mire come quelle di fanciullo.”“Sii caro, io t’en prego,” dissi allora a quel mio servo. “E’ pel ben che io ti voglio, ch’è paro a quel per mio Carletto che conservo dentro al core: è per ciò ch’io sì ti parlo. Le vertade ch’io gli narro, lui ch’è nervo, se le prende quale affronto. Ah, domarlo con ragione: è il pensiero d’ogni padre. S’io gli dico con affetto: impara, Carlo, a far di conto ché al mercato ladre persone incontrar potresti, lui un bacio mi regala e ricorda che sua madre, buona donna, purtroppo morta, cacio comprava e uccelletti nei negozi e imbrogliar non si facea. Lincio chi mi vuol fregar, ea dicea. Gli ozi altrui non han da diventar pesi miei. E non sapea di matematica che rozzi elementi. Perciocché io penso: si è i martiri dei figli quando istruzione vuoi dar loro e gli dici ‘i’ è ‘i’.” “La moglie tua, pur senza cognizione,” volli consolarlo, “dicea cose egregie.” “Eh, ma i figli ti fan sentir coglione.” E si smise di parlar di cose regie. S’addivenne poco appresso alla fonte d’un torrente d’acque pure fresche e ligie, che scendean forti e sicure da monte irto. Tosto abbeverai le budella mie assetate, lieto de l’arconte che tal natura creò sì bella e servizievole. Tommaso mise i pie’ a mollo e li movea nella letizia: pur senza capir, commise turbativa umana nel fluido scorrer de l’acqua de la selva: moto immise che pria non c’era. D’un colpo accorrer vid’io verso di noi un bel capriolo che stecchì a me dinanzi. Soccorrer esso non fu cosa, a mo’ di punteruolo conficcato s’era in suo fianco ramo solido e fino. Non si può dir che duolo mostrò Tommaso a quella vista: “Famo tosto grande arrosto di cotal fortuna,” esclamò a veder il corpo gramo levando dal rio l’arti suoi com’una Furia lontana da misericordia e posati essi al sol, senza veruna tema, venne e l’animal, che ricordi, a forza di tagli dissanguò per sfamarci. Io raccolsi molti legni: sordi a gola non eravamo. Del ciel squarci io vedea dopo de la selva il nero. Alle tre più non udimmo, a cibarci, trambusto di stomaci. Accorto m’ero che l’acqua e il cibo fan men tetro il buio de la mente, com’anch’è vero che non di solo pan... disse uno dietro. 106 II Lo giorno se n’andava e noi si giunse nei pressi d’un molino che grandi pale avea. La stra’ ch’ivi portava assunse largo aspetto. D’un tratto “L’assale,” sentimmo urlare da qualche parte e ci voltammo inver la vocale. Due omini vedemmo e un che parte, lancia in resta, alla presa del molino: cavalcaa come fosse un di Marte. Segaligno e con un becco, il divino ei parea voler sfidare: “Che tu fai?” gli diss’io ma lui era in suo destino. La sua lancia nella pala entrò presto, e un fracasso se n’avvenne: che lo cavalier fu sbalzato e restò pesto sulla terra a dolorarsi. “Chi melo dice ch’io sogno?” m’assillò Tommaso. “Codesta è realtà, i’ ancor mi gelo, ma il padron mio Chisciotte evaso è da ragione e tali cose face, perdonate, convien non farci caso,” fé lo scudier nel mentre noi si tace sorpresi e lesto ci sorpassa a soccorrer su sua soma il padron suo che piace a quelli strambi. Anco noi accorrer dovemmo, ché il cavalier stentava a rassettarsi e le braccia sua correr facea nell’aere e li pugni mostrava a minacciar il molino e gli annessi. “Gigante e drago,” viro gli gridava, “conosciuto ancor non hai li possessi di Chisciotte. Padron son de la romanza e m’avvalgo d’ogni arma ch’io lessi. Tu sei grosso: è da ciò che trai baldanza, ma i miei amici, sta sicuro, presto mi suggeriranno qual sarà danza che tu ballerai, qual’esca mio pasto ti renderà; dei saper ch’io son affine alla perseveranza: se son rimasto sempr’in vita, è per essa, che fine mai ha. M’è amico pur l’ardimento, ch’agisce me tramite per il fine suo, ragion per cui bollo e fermento dinanzi all’ingiustizia dell’esser tuo. Io son hidalgo e cotal mi sento nobile e nobil d’animo; or tu, o gigante, inchinati a mia persona ch’anzi ti sfidò e noi sarem un duo, ché nobiltà dimostra chi perdona al pari di chi perdonare si face, scendi orsù a mio livello, sprona te d’umiltà convinta, poiché spiace chi s’ammanta di grandezza inane; lascia che s’infiammino come brace le membra tue quand’io le rendo sane appoggiandoti esta spada su spalla sì ch’io fò di te un pari a me, fa ne la mente pensiero a ciò, ch’io non falla.” Detto questo, il cavalier il capo chinò e curare si fece dalla provvida mano di scudier. Daccapo volea ricominciare con lancia contr’il molino, a veder che sciapo era il desìo d’esso d’abbassar la faccia. Ma noi lo si trattiene e lo scudier, saggio per due, fa sì che il si taccia declamando l’amor che il cavalier nutre per Dulcinea del Toboso, donna di lignaggio alto e fier. “Esist’ella?” chie’ Tommaso sospettoso: truce lo guato e lui distoglie l’occhi. Intanto s’era l’ossesso a riposo collocato: “In attesa che scocchi, al risveglio, di nuova avventura il desiderio. Certo è che di tocchi siffatti lor signori mai in natura ebbero modo d’osservare. Sancio io sono e lui è don Chisciotte, pura creatura, signore de la Mancia.” Così disse l’uomo sollevandosi dal padrone disteso e la pancia davver prominente ponendosi fra sé e noi. I’ e Tommà c’inchinammo a presentarci e dimande gli posi, e col sole noi pure tramontammo da nostre celesti certezze, scossi nell’animo da quanto ascoltammo. Nel mentre che Sancio parlava, mossi c’eravam, io e chi m’accompagnava, per assemblar legna e fogli’e sassi, onde far fuoco sì che si cenava. “Dulcinea è contadina,” Sancio disse, “ma a lui nobildonna ella sembrava.” “Come il molino gli parea chi Ulisse chiamò Nessuno,” intervenne Tommaso e resti cosse di capriol che visse. L’aroma de la carne presto al naso giunse del cavalier ch’era dormiente e lui si svegliò: “Com’è che sto raso?” domandò a Sancio in pie’ s’ergente. Poi rintronato venne al fuoco e tetro dall’alto tutti squadrandoci veemente esclamò: “Chi sono, al desco nostro seduti, esti umani?” Sancio fe’ nomi mio e di Tommaso al cavalier. D’estro poetico preso, il c’informò che “Domi mai saremo a crudezza del mondo, io e Sancio e Ronzinante, com’i servi de la gleba che stan in fondo.” Quindi s’assise a noi accanto e carne dimandò per sue necessità. “Grondo di stima,” diss’io, “e di cibo farne uso miglior non si puote che darlo a compagni par te e Sancio, eterne figure di cui pensier si serve.” E passarlo personalmente a lui volli un pezzo di capriolo arrosto. “Tu pari qual Carlo,” si volse allor a me Tommaso, “e grezzo mi sento a dir ciò: tu grondi di stima, ma io grondo di sudore, ché mezzo capriolo è già finito e non per rima dobbiam cercar di che altro cibarci.” “Vien ‘compagni’ da ‘cum panis’, prima latino e che vuol significarci che obbligo è a dividere il pane.” “Ben mi sta,” Tommaso fe’ “son marci i dicitori contrari, ma grane il nobil nostro ci procura ché pure un tal Ronzinante vuol che rimane indomo e con carne nostra di cure vorrà fornire.” Ma prese Sancio a sostenere ilare, che “Di vegetali misture solo nutresi il Ronzin del cavaliere.” A sentir, tosto s’alzò il Chisciotte: “Vien Sancio,” ordinò rosso in viso, “ch’avere a mangiare la robba d’altri la notte nella mente apporta. Patiam piuttosto, sa di sale lo pane altrui: a dotte persone sentii dir.” “T’en prego tosto,” dissi in pie’, “resta,cavalier nostro, ché mio sento su sal’e pane il composto e Tommaso per pena lo fo Silvestro.” 186 III “Signor mio,” scattò Silvestro, “conservar voglio il nome ch’appartiene al core di miei parenti che sì soglion m’appellar.” “Giustizia mosse il mio alto fattore,” i’ risposi, “ché dar segno immediato devo all’ospite illustre: si more chi cavalleria non rispetta e nato al suo posto è omo di dolce stil novo.” “Pur che Silvestro m’hai rigenerato tu dolce non mi verrai, né ci provo.” “Or taci, Silvestro, ché il cavalier parlar vole.” “Significante trovo che al cenno mio Sancio, lo scudier non sollevò da nuda terra il dietro: è per tanto ch’intraprendo il sentier di tolleranza e perdono Silvestro tenendo per buona tua punizione; or consenti che m’allontani e l’astro lunare osservi da solo in funzione de la stima ch’io nutro pel mistero del creato tutto che mai si fa finzione.” Andato che fu Chisciotte, io m’ero seduto in terra, da Silvestro emulato e in me sentìa tristezza, invero. “Mangiate, amici miei,” esortò spigliato Sancio e del pane, tratto da suo sacco, ci porse con allegria e scarmigliato. “Che vi prende?” aggiunse poi, “che fiacco vedo il color vostro. Non fatevi intristir dal padron mio amato che d’acciacco suo non vorrebbe chicchessia investir. La giustizia ch’egli agogna e cerca giammai potremo su terra avvertir che s’abbia, seppur è bella ricerca.” “Tu parli come Tommaso,” allora dissi. “Son contento che dalla forca m’hai liberato e ripreso hai or ora a chiamarmi con il nome ch’è mio.” “Oh Silvestro, causa persa tu perora, poiché a Tommaso D’Aquino pio mi riferivo ch’è gran filosofo, di quei che pensan come piace a Dio.” “Che dicea costui, dicci, ch’io se so fo?” “L’Aquinate ritien che se io bramo Dio o la giustizia, tal’amor lo fo vero anche soltanto se tramo di percorrere la strada che port’a Loro, pur sapendo che non possiamo in terra far sì che tal méta sia scorta.” “Don Chisciotte invé, a ciò non s’adegua,” riprese a parlar Sancio, “vita morta chiama l’esister di colui che tregua offre a chi s’avversa a vero senza giustificazion altra che si segua il vantaggio proprio e non l’essenza.” Dimandò allor scettico Silvestro: “Cosa c’entra il molino con l’essenza?” “Non sempre io capisco, son maldestro, il modo di veder del cavaliere, quello ch’io posso dire è che m’addestro a capirne d’intelletto il volere. Or sentite la storia che racconto: s’andava noi due per il sentiere quando gli parve di veder affronto a l’idea d’omo libero ch’egli stima; in catene eran persone e lui pronto si fa per salvar costoro e mima ver duello con chi pon coercizione, sol che li veri banditi, che cima, eran gl’incatenati, a intenzione di guardie condotti, e il scioglie lestofanti rei e sfid’a tenzone chi per suo travaglio in lui incoglie.” Fu allora che vedemmo tornare Chisciotte il quale noi lieti accoglie; mentr’il siede noto baluginare su volto suo luce di fuoco che a spegnersi va: piacer non puote dare sua grev’espression’e l’amaro che a noi si trasmette dalle sue pupille quando le move perdute o che a cielo dirige a cercar faville d’un dio terren che l’aiuti in sua lotta e lui affermi che son più di mille coloro che combattono la rotta sbagliata che l’umano à intrapresa. Spande lacrime asciutte, lai sbotta che nessun ode, singulto d’intesa tien con la notte che il dì si piange. Tra parole e silenzi l’alba attesa alfin giunse, dirò senz’altre frange. E noi si riprese nostro cammino, di quei vivi che stanchezza nol tange, chi a pie’ chi a caval di Ronzino chi sulla groppa d’utile asinello per fame d’attraversar d’Unetrino fantasia che realtà si fece nello svolgere d’una sola settimana. Un gregge di pecore il cui vello lor pastori tiravan per far lana un po’ appresso a noi sbarrò la strada e l’ira del cavalier si fe’ frana: “Animali ovini e umani, v’aggrada dunque di separar la via futura di noi nobili viandanti cui bada il voler divino e che natura apprezza da lo percorso passato? Come osate voi por siffatta cura a fermar chi è strumento del fato? Tosto allor si mova, pria che mia lancia s’abbatta su scellerati che prato fan loro, al Signor della Mancia impedendo ed agli amici suoi di transitare nel modo che l’ancia fa passar il fiato che in suono puoi udir poi trasformato: s’obbedisca se saggiamente non si vol ch’io scuoi ruminanti e parlanti e sol lisca d’essi rimanga al fin di testimonio d’un’esistenza nata acché fallisca.” “Matto è costui?” dimandò un pastore a me rivolto nel mentre Ronzino avea preso a scalciar nervoso fore di controllo per via del gran casino, costringendo Chisciotte a prodigarsi per portar chi portava il suo bacino. “Il cavalier che noi onora parsi strambo ad occhi oscuri perché l’ingiusto teme e sovvertir vuole a indignarsi.” “La carne di nostre pecore gusto d’omini fa felice come latt’e formaggio e quant’altro: dov’è l’ingiusto del qual favelli? Come tu ribatte?” “Amico, nella sostanza s’impiglia il ragionare. Son però esatte l’interrogazioni su giustizia ch’il piglia.” 246 IV Come persona ch’è per forza desta io mi riscossi lo giorno seguente a sentir tuono che rompea la testa. Presto corremmo lontan da torrente dove la notte avevamo trascorsa per tema che l’acque, ch’amico sente chiare fresche e dolci, presa rincorsa, mostrassero l’impeto ch’è pur loro allorché quelle di cielo, percorsa l’aere, s’abbraccian a l’altr’e coro insieme fan ch’inonda ognidove. Grotta videmmo che sembrava foro indentro la roccia, fatto se piove per riparare, e lì ci ficcammo giust’in tempo ond’evitar che altrove noi si restasse e diluvio scampammo. Il coperto ci fè allegri tutti, pur l’animali e insiem cantammo lodi al creato ed a’ suoi belli frutti nel mentre le gocce cadean fitte all’esterno e assorbivan luce. Quand’ecco una voce udimmo: “Bitte, io son mago di Germania e in fond’a grotta sto: so che siete genti invitte.” Ci voltammo lesti in direzion d’onda sonora e dall’oscuro grosso venn’e alto omo vecchiardo che di monda veste bianca vestia e Sancio svenn’e cadde per cu’io stava a lui andando ma braccio di mago lontan mi tenn’e sua voce tonante a me parlando rivolse: “Non ti curar di sincòpe, poiché io so ch’il si va rianimando; altra è tua missione: dentro l’Europe intière tu dèì equilibrar li matti facend’uso di mezzi tutti e rope che l’art’e resto e li strani fatti metteranno alla tua disposizione.” “Pope, già m’hanno sfinito tuoi patti” il dissi “che son forieri d’azione lunga e rigorosa pur se lusingan mie cervella disposte a tensione di questa natura; ma che non fingan mie virtù: m’obbligano esse a dire che per tal impresa occorre che cingan la spada de l’intelletto l’ardire e la misura non d’uno soltanto ma di gente d’ora e de l’avvenire, ché far da solo neanche un santo puote e per darti a capir quant’è dura è come s’io ti dicessi: intanto ch’equilibro li matti nostri, cura tu d’andar in Cina alla veneranda età che hai raggiunto e ch’è matura.” “Sancio è morto e saluti vi manda,” sentii allor dire a Silvestro chino su corpo di scudiero e che sbanda, quasi cade, mentre s’alza e di vino corre a imbeversi il gargarozzo finché fiasco ne contiene, fino a colmar di spirto il vuoto mozzo che morte lascia in alma di vivo. “Ei non dovea morire in sì tozzo modo e lontan da suo vero arrivo,” disse mago irato mentre Chisciotte inginocchiatosi ponea su schivo viso la mano sua e gli diè notte abbassandogli palpebr’e clamando: “Sancio, amico e custode, di lotte mie ti meravigliasti fin a quando comprension di me cielo ti offerse. All’istessa maniera io comando creato acché com’è ch’io ti perse mi renda dotto. Non è abbastanza dir per sincope o d’altro: ch’io sappia la causa ultima, qual sostanza in te marcì prima e di veleno inondò ‘l tuo corpo e la prestanza da esso fece che venisse meno. In questa grotta fuor da tuo paese in mentre che diluvio senza freno s’abbatteva su campagna cortese tu te n’andasti solo e d’improvviso e raggiungesti l’antenate imprese. Con chi di Dulcinea dirò? Viso suo chi mi descriverà in presenza come tu facei? Asinello ch’è piso non sentirà egli assurd’assenza? A questi nuovi amici, sta sicuro, di te parlerò e vedrai ch’essenza tua si tramanderà dentro futuro.” Ciò detto il cavalier si sollevò e uscì da grotta e s’immerse puro in diluvio e noi videmmo che levò braccia e capo e Cristo di spalle parve. Silvestro lacrime da sacca prelevò senza cessa e in quantità e scomparve in parte buia di grotta e lai emise. Il mago benedì e disse: “Larve tua carne mangeranno presto, lise saranno tue indumenta, nessuno però nessun mai, l’anima…” e rise. Poi venne a me e dimandò se uno come lui potea prender posto di Sancio e partir con noi in cerca dell’Uno. “A trovar la retta via i’ mi lancio e Silvestro m’è guida, di ragione pare ch’abbisogna più che del rancio l’amico cavaliere ed è questione che tal fini nostri ben conciliansi nell’Uno tuo e che noi amiamo al par di quelli che d’amor saziansi,” risposi a mago e poi con Silvestro lì vegliammo come morti vegliansi. Dalla grotta sotto un pino silvestro si vedea Chisciotte ch’era accucciato incurante di pioggia e per capestro sembrava ei pronto, addolorato oltremodo per morte di scudiero. Fulmine l’illuminò che levato dito a cielo e sguardo, Dio davvero volea tacciare di sua mestizia. E Signore l’udì come chi cero in chiesa pone per chieder giustizia. E venne sequela di tuon’e suoni e lampi fatti da Chi tien perizia per cui tra le stupite acclamazioni nostre s’ebbe a compiere miracolo e Sancio si svegliò da perdizioni. E sfregati l’occhi disse: “Cavolo, che bella dormita ch’i mi son fatta, e voi perché come attorn’a tavolo state intorno a me? Com’a chi si schiatta.” Di gioia esultò Silvestro e baci gli dava e abbracci e sulla tratta di Chisciotte poi si mise. “Or taci,” diss’io contento, “ché noi ti si credea da sincope stroncato e cor in paci.” “Che si rianimava io così dicea,” parlò il mago felice e sbalordiva Sancio a saper che morto lo si facea. Ed ecco tornar Silve’ cui seguiva fradicio cavalier che suscitato afferrò e fè sollevare e viva espressione riapparvegli e beato dipoi si quietò e solido disse: “Amico, sorprese che fa il fato son impossibili a sapersi: visse chi more, il resto è fanfaluca.” “Per festa e per rima,” io pure disse “occor che Silvestro si faccia Luca.” 17 V “Luca o Silvestro, per me pari sono,” s’offese Luca, “e chi così vuolsi io non dimando per non farti dono.” E, pioggia cessata, in tutti colsi desiderio di riprender cammino. Ultimi dubbi a mago di nord i’tolsi, che c’accusava di non parlar latino, al dirgli che si voleva far lode in lingua nova al Signor Unetrino. “Grotta che m’accogliesti, odi l’ode ch’io ti fo dopo lustri e decenni: custodisti mia solitudine da mode fugaci consentendo che perenni meditate preghiere s’instillassero in mente e cor miei siccome cenni che per tramite d’anima venissero da Lui diretti al fin che l’incontro. Grotta che m’accogliesti, tal passero solitario e derelitto ch’à contro lo tosto inverno che tutte stagioni pervade allorquando si fa scontro col voler di Dio e m’infondesti ragioni: ‘amor, ch’al cor gentil ratto s’apprende’ ‘amor, ch’a nullo amato amar perdona’ grotta che m’accogliesti, si comprende il desio dell’anima che d’un lato al dovere di lasciarti s’arrende inquantocché capì senso ch’Amato ‘l cerca pure nell’Africa fonda e infra l’amici novi ch’à mandato, d’altro lato restar sulla tua onda vorrebbe che sì in alto l’ha porto. Grotta che m’accogliesti, amor diffonda.” Questo pregò il gran mago assorto ma Luca repente dir volle la sua: “In Africa i’non vegno ch’è corto il fiato in tal calura e il sole tua pelle nera fa diventare e nessuno ti riconosce quando qui si fa prua.” “O Luca che sì ti chiamò alcuno invé che Tommaso com’è giusto sia, nel far cammino i’ ti conto di veruno. Dei saper che erba di farmacia fu scoperta oltre l’oceani bagni e ad essa dié nome Levis Cia lo ‘mperator di tali lochi stagni per onorar san Luigi e Ciacco dell’Anguillara poeta fra i magni. Tal erba, Sancio t’assicura, smacco da a chi ti pensa male e danno face, ti basta che l’assumi, pofferbacco.” “I’ non vuol far male a Luca, pace voglio, com’anche Chisciotte tuo padrone, e tu sobilla mia guida verace a qual fine io non so e gli da’ sprone,” intervenni contrariato, ché poeta à da pensar a l’universal questione e non mai a due servi di cui à pieta. “E allor Tommaso rinomar devi l’amico mio che sol così s’allieta.” “Pur che tu se’ resuscitato ‘devi’ non puoi dir a chi salaria Luca,” intervenne cavalier, “ch’io mi levi in difesa d’ospite e vero duca si necesse, causa tua sciocca richiesta.” “Fate zilenzio,” fè allor a mi’ nuca lo mago di Germania, “hodie si festa Tommaso l’apostolo e per ciò motivo i’ m’appello acché Luca s’arresta e torni Tommaso per spirto votivo.” Al declinar di giornata, locanda videmmo in su la via e sentivo appetito grande com’altra banda. Ci rifocillammo di carnagione e infin satolli, prima di branda, i’ dié parola a l’universal questione: “Essere o non essere,” declamai ispirato da beata libagione. “Non è questo il problema più ormai ché noi già siamo e non v’è niuna scelta.” intervenne Chisciotte e duro ‘l guatai. “Per poeta è l’essenza prescelta cosa? Il nostro cavalier ch’assale…” io stava argomentando ma la svelta lingua di mago introdusse strale e non mi lasciò terminar concetto: “Non è tempo di question campale. E luogo nemmeno: pranzo diletto non s’addice all’esserenonessere, teschio piuttosto, dolore, sospetto.” “Se nol dico io, altro poeta d’essere dirà” conclusi indispettito assai addentando coscia di carni tenere. “I’ pure son convinto, ch’ora pensai che d’essere e questione ho orecchiato innanzi, ma in modo sì fine mai,” disse cavaliere ver’me voltato. “Comunque,” parlai pria di deglutire, “che vuoi significar, o mago? Grato ti sarò se spiegar mi vorrai d’ire tue ragione, ché a coniugar verbo ‘essere’ poeta d’ogni tempo mire. I’ non credo ch’a dir tempo acerbo il nostro per mio poetar tu abbi’a riferirti a pranzo: tal senso serbo.” “Con onestà t’ho da spiegar che rabbia tua un fondamento habe, seppure io non dissi ‘acerbo’ poiché gabbia son luogo e tempo per le menti dure. In esto momento i’ penso, al pari di Chisciotte, e profittando di pure gioie di pasto e compagnia, che Lari vuole che noi s’è per fatto d’essere.” “Or tu pensa lecito mio dialogari? Questo vogliamo sapere: s’essere o non essere io sono libero di dimandarmi. O debbo cedere?” “Libero tu se’ per nulla, ché l’ebbero fatto tuoi genitori vero inguaio perché quando tu non eri t’avrebbero dovuto dimandare: vuo’ tu Caio essere? E se tu ‘l dicevi che no, non s’avevano ad alzare il saio.” “I’ mi pento nel mio petto: te no, Tommaso, io non dovea contentarti, dovea lasciarti nome altro, se no t’esalti e non c’è facile domarti.” “Tu può domar cavalli o Beatrice tua, se pure riesci ad accasarti.” “Suvvia, compagni di desco, felice renderete tavolata e mia panza, ché Sancio Panza si cognoma, si ce lasciate digerire in pace e sanza guerra prelibatezze d’ostessa.” “Sottoposti, calmate vostra danza, v’ingiunge cavaliere, che è fessa.” “Io pensa ch’ho sbagliato la valuta d’anime esta sera, abituarmi a ressa io devo dopo grotta: qui si sputa sofferenza, è questa la vertade, ma esserononessere, i’non muta, per tempo e per luogo qui non cade.” 57 VI Al tornar de la mente, sulla branda me ne stetti a meditar finché mago da giaciglio accanto fé scorribanda: “A veder lo ‘nferno i’ sarei pago.” “Tu vuo’ cercar l’Uno laddove non c’è?” dimandai stupito da cotal imago. “Tu pecchi di logica” il disse “C’è se cosa è. Sua voglia fè l’essenze.” “Ma scusa” volli dir “quando error c’è io oggetto getto e di su’essenze non m’occupo e più non m’appartiene.” “Son sua proprietà tutte create essenze.” “Ma se son sue, perché error mantiene e nol corregge, perché male resta?” “Perché lo male fa ‘ntravveder lo bene.” Sensazione di fame in me si desta d’un tratto e ragion di mago mi sovviene ché pagnotta saria gradita festa per mio stomaco al par che bene dopo il male. Ma poi feci mente che se pagnotta manca mal si tiene l’affamato assai e ferocemente. Mi distrasse porta che s’apr’e sbatte: Tom comparve con pane eccellente e a tutt’il distribuì con latte. Cammino di ricerca riprendemmo attraverso querceto pien di blatte. I’era orripilato ché mai videmmo sì tante di schifezze ambulanti. “Noi siam schifiltosi ma ci pascemmo par loro d’umori materni santi,” disse Sancio con saggezza nel mentre ne schiacciav’a bizzeffe e suon di franti scheletri mi facea rivoltar ventre. “Ch’ogni scarafaggio piace a su’ mamma, se questo vai dicendo, tu fai centr’e son certo,” Tomma intervenne, “dramma non è. Non è vera, mago, ‘sta cosa?” “Mente mia, pur che non vuoi, tu infiamma, ché io t’ho da dir in versi e prosa che non si dee insiem menzionare blatt’e mamma, meglio è mamm’e rosa.” “Per tempo e per luogo?” volli commentare. Sortimmo infin da querceto infesto e ci accompagnammo nell’andare ad acque di ruscelletto ch’innesto poi fa in rio più ampio e turbinante. All’ombra d’un pino demmo arresto al fin d’abbeverar noi e Ronzinante e asinello. Nel mentre Chisciotte, con mano su cavallo, contemplante si mostra di paesaggio e di grotte io parla con mago, Tommaso e Sancio con rami spuntati tra pesci a frotte s’immergono e pugnano per rancio. “In ultimi dieci anni,” mago dicea, “solitudine mi fece acconcio a meditar su eucaristia ch’è dea de li cristiani. I’ m’addimandavo come si concilia in chi si bea dopo confessione il desio bravo de l’ostia con certezza ch’ei ricader dovrà in tentazione che n’è schiavo.” “E scaturì in tal tempo tuo parere da siffatta questione o sta sospesa?” “Ardua e una soluzione potere trovar potè e son qui a mò di resa.” “Non m’è facile comprender tuo dire, mago,” m’espressi con chiara pretesa. S’avvicinò Chisciotte a sentire tono di conversazione e mago mano il prese e la mia e zittire ci fè con sibilo sommesso ma drago mi parve per tension che fu creata, e fiamme e non fiato ch’al par d’ago pungean superficie ed essa passata entravan’ profondo uscir videtti da sua bocca: “Dev’esser accettata l’umana natura da spirti schietti: ch’è pur debole carn’e mai perfetta. E i’ son qui omo tra omini, eletti di lassù al fin d’essenza imperfetta e che possa lodar la creazione che mercè di carne i’vedo perfetta.” Su brace ardemmo, per soddisfazione di stomaco, parte de lo pescato. Nel mentre si mangiava, un cafone coll’aratro e bue viene educato verso di noi e caffè ci domanda. “Noi non abbiamo il da te cercato, sol pan’e pesc’e acqua per bevanda,” il diss’io e Chisciotte aggiunse: “I’ conosco tal frutto che comanda sveltezza e rende prodi pur chi smunse d’energia la materna natura. Chi sei tu che detta sostanza assunse?” “Osvaldo mi chiamo e quivi dura mio esilio dacché mi fu accusa che lo’mperator uccisi: è dura.” “Quale ‘mperator” i’chiesi “tu usa?” ma mago intervenn’ e cafon scosse: “Non ti curar di noi, ma prendi e scusa” e pan in bocca gli porse e lo mosse. “Io vò sentir,” dissi “l’historia tutta.” Ma fu allora che terra si smosse e più non finìa e larga e brutta s’aperse fossa e profonda e si corse no’in ogni direzion che Dio butta. Paesaggio mutò alfin e i’morse di paura e l’altri pure e burrone laddove stava ruscelletto sorse. Poi tutta si quietò l’insurrezione di celeste mano ch’i contraddico e per timor non dico. In azione Osvaldo morì e non disse nemico. 147 VII “Quest’è Satan, quest’è Satan, Chisciotte,” urlò cavalier a fin di terremoto, “el diablo solo puote far a botte con la terra madre da su’ remoto regno e spaccarla e dividerla.” Ci sedemmo a rimirar l’immoto che moto segue e com’una perla ch’è cancro d’ostrica i’ poetai: “Quiete dopo tempesta: ah, vederla.” Tommaso s’occupò d’Osvaldo guai : pietra colpito l’avea su testa e fracassata e ‘l cervello ormai sporgeva siccome materia mesta e inerte e ‘l nulla emanava d’esso, più mai desio vi resta, non gioia o bellezza, solo bava bianca e rossastra che fazzoletto di mia guida coprì per pietà brava. Mago pregò assorto e su petto di morto croce tracciò colla mano. Sancio e io e cavalier al cospetto pure stavamo, in piè, de l’inano. Occhio mi cadde sopra pergamena di tasca d’Osvaldo sortita e strano la presi ed ivi lessi de la pena de lo ‘mperator Giovanni e poi di Roberto principe e de la scena. Era Giovanni, ed i fratelli suoi principi, di spirto pugnac’e fiero. Li nobili de lo reame tutto, coi vassalli loro, cedettero l’intero dominio e potere a la sua famiglia, vecchi o nuovi ch’eran de l’impero. Tranne un barbuto Cid che piglia e s’asserragli’e si ribella colli amici comuni (‘sti tipi) a miglia poche da florida sua terra, folli tipi, intr’isola avana che ruba a utile servo de lo grand’impero. Tosto Giovanni a guerra con tuba move li mulatti, ma ciò non basta. E deve pur contener quei cu’ “bah!” detto non serv’a spaventar, ché casta si senton e di lignaggio e chiamano “ma fìa,” ossia figlia mia, la pasta venefica dove tengon l’una mano e l’altra; e l’aiuta frate Roberto. Lo quale a giustizia tiene e vano è tentar di render meno sofferto suo percorso di vita coll’induzion a ragionar maschio com’è certo cosciente chi bene sape che l’azion violenta è fonte unica di gioia e sicurtà nel nostro mondo d’elezion. Pur che li sudditi, per dì di noia, bionda donzella a lo ‘mperatore donano, ella non gli calma foia e Giovanni s’inguerra a tutte l’ore in conflitti or giusti, or non giusti, pur d’eliminar l’assai testosterone. Ma tutti ‘l rispettano per suoi gusti sani e chi l’ammazza, dalla sera alla mattina appresso s’angusti per tutta vita, sì spero s’avvera. Donna Lina, di Giovanni consorte, con lui galoppava mattina ch’era destino ‘mperator non vedesse notte. S’era la corte spostata nel contado al fin di riscuotere gabell’e morte sovvenne per saetta che in grado fu di perforar tempie di Giovanni e sua materia di pensiero si fè brado cibo d’animali bradi e li danni non furon rimediabili ché Giovanni cadd’e morse senz’altri affanni, ma dovea campar ancor degli anni, se balestra la vita di Giovanni stroncata non avesse co l’inganni. Ulivo indicò cafone e panni d’Osvaldo e, papiro conta: “i’ cado d’albero, ove a mò di barbagianni m’era appollaiato, su prato rado e tutti a dir: ‘l’uccisore’ e botte piglio e l’esilio e ramingo vado. Ma non fu’io l’arbitro de la sorte de lo ‘mperator, ché d’altro ulivo partì saetta che dì gli fece notte.” |